Nel corso della storia, Islam e Occidente si sono reciprocamente influenzati, a volte anche a distanza di secoli e seguendo traiettorie insospettabili. In questo capitolo di Nietzsche in paradiso (Mimesis Edizioni, 2021) Francesca Bocca-Aldaqre, teologa e docente di Cilvità islamica, ce ne offre un esempio mostrando le connessioni tra il pensiero di Martin Heidegger e del filosofo e mistico arabo ibn ʿArabī.
Nella foresta fitta di tronchi, di tanto in tanto, si apre una radura.
La luce aiuta gli occhi a spingersi oltre, per ammirare, anche se per poco, il panorama più vasto e più bello. Per Martin Heidegger (1889-1976) le caratteristiche etimologiche della Lichtung – radura – sono l’essere illuminata e il diradarsi; ecco ciò che concede spazio all’apparizione dell’Essere.
Al cuore può essere donato, d’improvviso, uno spalancamento. È l’apertura – futūḥ – cardine del pensiero di Ibn ʿArabī (1165-1240). Fino a quel momento, futūḥ significava tutt’altro: il rovesciamento di un regime ingiusto, la liberazione dall’oppressione che permette finalmente l’arrivo del messaggio dell’Islam, che appunto “apre” una via.
Radura – Lichtung – in Heidegger, e apertura – futūḥ – in ibn ʿArabī, descrivono una stessa condizione dell’umano, necessaria affinché si manifesti l’Essere.
Radura e apertura descrivono, senza essere metafora. Ogni metafora è infatti radicata nel pensiero metafisico, ed esiste solo in virtù di una distinzione tra sensibile e non sensibile, distinzione che cade nel pensiero originario.
Heidegger e ibn ʿArabī, nel descrivere lo stesso atteggiamento, sanno che l’individuo non può esso stesso spalancare o osservare l’Essere, ma soltanto procurare lo spazio necessario affinché si manifesti, prendendosene cura.
La manifestazione, quasi uno strappo del velo nella valenza onomatopeica di futūḥ, rimane imprevedibile. La venuta dell’Essere non è come risposta a una domanda, ma dono o favore conferiti all’uomo. Quest’atteggiamento originario, questa cura, sono in ultima analisi l’autentica speranza di salvezza: “Lo svelato – das Unverbogene – è anche il salvato – Geborgene”. Heidegger, filosofo, è in verità il pastore dell’essere, il custode del pensiero.
Ibn ʿArabī, teologo, ad oggi accusato di miscredenza dai più letteralisti tra i musulmani, non può nemmeno ridursi a un mistico. Il suo pensiero incorpora, senza fare sintesi, “logos e rivelazione”. Oltre a questo orizzonte, a questo duro lavoro di cura, può avvenire qualcosa.
In Heidegger si tratta di un evento – Ereignis, o una svolta – Kehre, in cui il pensiero ringraziante si fa suono. In tedesco, l’appaiamento denken-danken, che evidenzia la somiglianza etimologica tra gli atti del pensiero e quelli della gratitudine, è quasi uno scampanio, tutto di gioia: “in questa possibilità si trova una gioia incrollabile”.
L’apertura di ibn ʿArabi non è suono ma immagine: Sophia aeterna, principessa greca, lo rimprovera per aver così a lungo cercato risposte intellettuali a domande per loro natura mistiche.
Quando Sophia si mostra a lui “nel suo manifestarsi vi fu una tale dolcezza da provocare in me gioia, emozione e delizia”.
È follia affermare che “nulla sia senza un perché”, è follia il principio di ragion sufficiente di Leibniz. L’intuito della realtà delle cose arriva a Martin Heidegger leggendo una poesia del mistico Silesio:
La rosa è senza un perché, fiorisce poiché fiorisce
Senza cura di sé, non domanda, non le importa essere vista. Il senso comune, invece, al perché fiorisca la rosa fornisce ragione su ragione. Le condizioni del suolo, le caratteristiche del clima, l’esposizione al sole, insomma cause tangibili fanno a gara per fornire, anzi, per essere il perché.
La spiegazione di Heidegger è chiara: “la rosa ha una ragione, ma non la considera (achtet nicht), né la domanda (fragt nicht)”.
Anche se Heidegger non svaluta le ragioni, nondimeno la sua spiegazione del principio di Leibniz è oracolare:
È ora evidente che il luogo di nascita del principio di ragion sufficiente non giace né nell’essenza dell’affermazione, né nella sua verità, ma anzi nella sua verità ontologica, cioè nella trascendenza stessa.
Un’intuizione – o forse una risposta – arriva da un’altra lettura oracolare dello stesso principio. Per ibn ʿArabi ogni attribuzione di ragione, ogni tentativo di individuare una causa, è un vano sforzo di “appropriarsi” dell’Essere, che rimane sempre, secondo l’intuizione di Heidegger, nella trascendenza stessa.
Quando una persona pensa Dio razionalmente, crea ciò che crede per tramite del proprio pensiero. Quindi, considera un dio ciò che egli stesso ha creato con il proprio stesso pensiero. Non è una materia lieve quest’errore.
Per ibn ʿArabi, permettere a Dio di essere soltanto ciò che il pensiero consente costituisce una delle forme del peccato più grave della tradizione islamica, l’idolatria.
Che differenza ci sarebbe tra chi, secondo l’espressione coranica “fa dei propri desideri un Dio” e chi invece antepone allo stesso Ineffabile un qualunque principio di ragione?
Infatti, gli “dei del pensiero” sono costruiti a immagine e somiglianza del pensatore. È in ciò che l’idolatria mostra la propria arroganza.
Dio è conoscibile soltanto in quanto Egli non è noto! Il conoscitore di Dio non trasgredisce il proprio livello. Sa di essere uno di coloro che non conoscono.
Heidegger, notoriamente, rifiuta la teologia. L’Essere di Heidegger – non si fa altro che ripetere – non è Dio, ed è però un Dio ben diverso da un Gott cristiano quello che ci si trova davanti leggendo ibn ʿArabi.
Heidegger non lascia spazio a Dio, perché potrebbe rischiare di cadere in un concetto metafisico – lo spiega in Identità e Differenza – lasciando tuttavia uno spazio per la nozione del “sacro”. Alcune letture, specialmente francesi, del lavoro del filosofo sono arrivate a definire il suo pensiero “una teologia senza teofania”.
Heidegger, però, si esprime chiaramente nelle sue lezioni a Marburgo. Agli studenti propone una distinzione: la filosofia è la scienza dell’Essere, ed è “assolutamente” diversa dalla teologia, che è invece scienza “ontica” di una particolare regione degli esseri, e non dell’Essere universale. Ciò che è meno noto è la critica, per lo stesso motivo, della teologia islamica da parte di ibn ʿArabi.
Le due teologie islamiche – la negativa degli ortodossi e la positiva dei razionalisti – “intellettualizzano, assegnano un limite all’illimitato riducendo l’Essere a un’opposizione binaria”.
Nello scrivere il suo capolavoro, le Illuminazioni Meccane – Futūḥāt al-Makkiyya –ibn ʿArabi si avventura nella metafisica, alternando prosa e poesia, includendo la sua autobiografia e dedicando un capitolo alle donne – sante, beatifiche – che l’hanno guidato all’illuminazione.
Ciò che rimane escluso è proprio il trattato teologico dell’Islam classico.
Ben conscio di ciò, aggiunge una prefazione alle Illuminazioni.
Racconta una tentazione che ha avuto, “di tanto in tanto” durante la composizione del libro, quella “di includere all’inizio del libro un capitolo riguardante il credo teologico, supportato da argomentazioni chiare e prove schiaccianti. Mi sono però accorto che ciò avrebbe solo distratto il lettore”.
Una distrazione, la teologia, da quel domandare che è la pietas del pensiero.
Primo traduttore di Heidegger in francese, Henry Corbin sceglie Cos’è metafisica per introdurre il filosofo tedesco all’ambiente francofono, nel 1938. Si sono conosciuti poco prima, nell’estate di Friburgo.
L’anno successivo, invece, Corbin verrà incaricato di reperire manoscritti persiani a Istanbul, e inizierà il lungo soggiorno in Oriente che lo porterà in Iran. Là conoscerà la spiritualità dell’Islam sciita, di cui si farà riscopritore della tradizione gnostica.
Nel 1976, in un’intervista per Radio France-Culture, il filosofo Philip Nemo tenta di mettere assieme queste due fatiche, senza riuscire.
È confuso dalla diversità di lingue, di origine e di eredità; considera i due grandi lavori di Corbin ed esclama: “Come possono queste due opere essere riconciliate come appartenenti alla stessa persona?”
Non è solo uno stupore di fronte alle competenze – seppure vastissime e inusuali – di Corbin a spingere Nemo allo stupore, ma un’idea di appartenenza: “Martin Heidegger considera l’Occidente come sua patria; la sua filosofia è tutta tedesca ed è davvero difficile riconciliare la traduzione di Heidegger con quella della teosofia iraniana”.
La titubanza di Nemo pervade l’Occidente.
Corbin, nella sua risposta, si scaglia contro la categorizzazione, contro “l’etichettamento aprioristico delle nostre discipline”.
Se solo i Francesi riuscissero ad immaginare, se solo intuissero “cosa significa essere filosofo, e cos’è la ricerca filosofica, se sapessero immaginare per un momento che le differenze linguistiche sono soltanto dei segni che si trovano sulla via, annunciando varianti topografiche secondarie, forse sarebbero un po’ meno stupiti”.
La risposta non è bastata a Nemo, e non basta ora a soddisfare il lettore.
L’Islam e il suo pensiero rimangono tutto fuorché una variante topografica, nell’immaginario collettivo. Per Corbin, addentratosi così a fondo nello gnosticismo, l’alterità dell’Oriente pare svanire, e non sembra quindi costituire un problema la ricerca, l’accoglimento dell’altrove nella filosofia. Non così era per Heidegger, però.
Intervistato dallo Spiegel, discute l’avvicinarsi di un possibile “rovesciamento” dell’Occidente. È necessario che esso trovi la propria essenza, ma al tempo stesso “ciò non può avere luogo tramite l’assunzione del buddhismo zen o di altre esperienze orientali del mondo”.
La nuova alba dell’Occidente, terra che tramonta – Abendland – ha un prerequisito: “Il pensiero viene modificato solo da quel pensiero che ha la stessa provenienza e la stessa destinazione”.
Heidegger, nelle sue vaste osservazioni, non discute mai l’Islam.
L’Oriente, per lui, è Taoismo e Buddismo, dei quali accoglie concetti, passaggi, espressioni nei suoi lavori. Heidegger non conosce ciò che Corbin, congedatosi da lui, incorpora in sé.
Sollecitato a indicare la via per il rinnovamento dell’Occidente, per il superamento della tecnica, è costretto ad ammettere: “Io non posso aiutarvi”.
L’intervistatore lo stuzzica, si chiede come è possibile che un filosofo non possa aiutare nel tracciare la strada del pensiero, e Heidegger affida a un sussurro l’impossibilità:
“Proprio così, non posso”.
Corbin, invece, è chiarissimo nel fugare un dubbio, anzi un timore.
L’Occidente teme che comprendere in sé il pensiero dell’Islam cancelli la propria identità.
Corbin quindi svela: Heidegger non è un’origine, e ibn ʿArabī non è una meta. Lui stesso non si allontana dall’Occidente, non ha bisogno dell’altrove per trovare la verità delle cose.
“Il lavoro del filosofo deve comprendere in sé un campo abbastanza vasto da permettere che pensatori visionari come Jacob Boheme, ibn ʿArabī o Swedeborg vi possano sedere assieme. La meta è includere lavori scritturali e idealisti – imaginali – e che tutti possano farsi contemplazione filosofica. La filosophia, altrimenti, cessa di avere alcunché in comune con la sophia.”
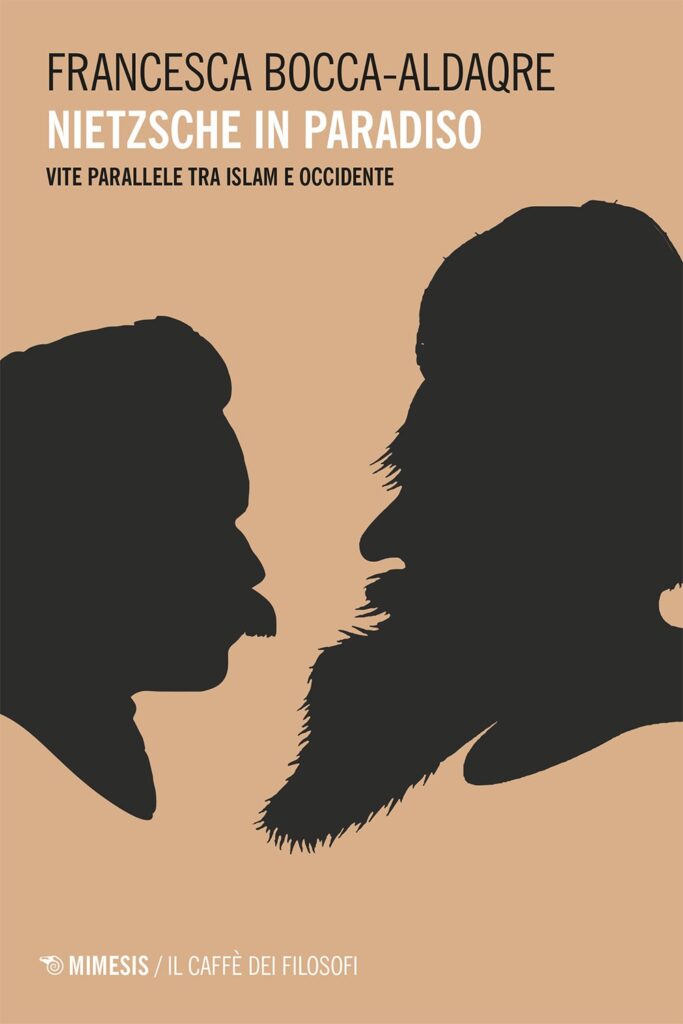
Per Corbin, la germanicità di Heidegger e la persianità di Ibn ʿArabī, anzi gli stessi luoghi dei suoi viaggi, “Friburgo, Tehran o Isfahan rappresentano in ultima analisi città emblematiche, simboli di un viaggio permanente”.
Il cercare e il trovare rimangono i medesimi: “Quello che cercavo in Heidegger, e che Heidegger mi ha aiutato a capire, era la stessa identica cosa di quello che cercavo in Iran e che la filosofia persiana mi ha mostrato”.
Vi è, poi, in questo andare e tornare tra Germania e Persia un esercizio ginnico del pensiero e della lingua.
Corbin è filosofo, ma si considera sempre traduttore, ovvero colui che ha introdotto, portato con sé Heidegger e ibn ʿArabī, rendendoli a tutti gli effetti parte del pensiero francese.
In questo compito, Heidegger è stato palestra: “Credo che sarebbe stato molto più difficile tradurre vocaboli di ibn ʿArabī se non avessi avuto l’allenamento nell’acrobatica richiesta per tradurre lo straordinario vocabolario tedesco che si incontra leggendo Heidegger”.
Il percorso di Corbin tra Germania e Persia è sempre circolare: tramite uno trovare l’altro, e appaiando asola e bottone, chiudere, riunire, risolvere qualcosa di ancora non pensato, e non ancora detto.
La proposta di Corbin non ha convinto l’Occidente.
Accusato di “aver confuso Heidegger con Sohrawardī”, il suo contributo accademico è tuttora recepito come rilevante per l’islamologia o la persianistica, non certo la filosofia. Anzi, il suo pensiero stesso è apprezzato dagli gnostici, ma ridicolizzato ugualmente da razionalisti e credenti ortodossi.
Di fronte a un Nemo ancora incredulo, Corbin presenta però l’incontro definitivo:
“Heidegger apparecchia tutta l’ambiguità della finitezza umana attorno all’esserci-per-la-morte – Sein zum Tode – mentre per ibn ʿArabi essere presenti in questo mondo è in realtà un esserci-per-oltre-la-morte”.
Né Heidegger né ibn ʿArabi lasciano dietro di sé qualcosa che si possa definire un sistema.
Non una summa, non una critica.
È la volontà di indicare una strada.
Vie, non opere. Pochi giorni prima della sua morte, Heidegger annota questo motto sulle prime pagine del volume che raccoglie i suoi primi scritti.
Il suggerimento, o l’auspicio, apre oggi l’edizione completa delle sue opere, edite da Klostermann. Il volume, sollevata la sovracoperta grigia e il blu brillante della copertina, istruisce nuovamente il lettore: “Vie, non opere”.
Indicare è anche lo scopo dell’opera di ibn ʿArabi, che “deve essere compresa come una scala Wittgensteiniana, una che cioè possa essere calciata via da sotto i piedi quando si è raggiunta la cima”.
Un sistema è un’entità stabile, ripetibile.
Un evento, invece, non è, ma accade.
Il continuo accadimento che è Dio è il motivo per l’abbandono di ogni sistema da parte di ibn ʿArabi:
“Descrivere Dio è restringerlo; predicare la sua Essenza è costringerlo. Chiunque pratichi la teologia, infatti, forza Dio a ripetersi più e più volte, forzando quindi Dio ad essere banale e prevedibile”.
Nell’Evento, Heidegger descrive lo svelamento e il nascondimento dell’Essere, che è accaduto dai Greci al presente. Questo non volere elucidare un sistema, non lasciare una sintesi organica, è stato spesso ripreso dai critici di Heidegger nell’etichettarlo come “più mistico che filosofo”. Per altri, il suo rifiuto delle categorie e perfino del lessico filosofico è “tale da mettere sulla difensiva qualunque potenziale critico”.
Heidegger è però ben capace di sistematizzare. La prova è in un piccolo libro, il gioiello Was heißt Denken? [Cosa significa pensare?], in realtà trascrizione di un corso universitario tenuto tra il 1951 e il 1952 a Friburgo.
Hannah Arendt – filosofa, confidente, amata – è l’unica a capirne il valore: “Cosa significa pensare? è importante tanto quanto Essere e Tempo. È l’unica presentazione sistematica del suo pensiero”.
Non è un caso che agli studenti Heidegger parli con chiarezza e sistematicità. La via per apprendere il pensiero è metodo e rigore mentre, arrivati alle porte della filosofia, si spalanca ciò che il sistema non può nemmeno accennare.
C’è il palese e c’è l’occulto. C’è l’immanente e c’è il trascendente.
Nella dogmatica classica, è questa l’unica differenza a esistere, ed equivale ad affermare: c’è Dio e c’è la Creazione.
Immanenza e trascendenza – ibn ʿArabī insiste – esistono invece simultaneamente.
Insistere sull’una o sull’altra porta a un grave errore:
“Insistere sulla Sua trascendenza è limitarlo, e insistere sulla Sua immanenza è vincolarlo”.
Terra e cielo, divini e mortali, non esistono in semplice opposizione.
Sono, anzi, una quadratura – Geviert.
Componendo abitanti e luoghi, scaturiscono i quattro.
L’ordine del cosmo, la divisione della sua responsabilità in quattro poli è il cardine della dottrina di ibn ʿArabī degli awtād: quattro guardiani trascendenti le cui opere sono un “perseverare” di Dio nel cosmo.
Simili a punti cardinali, i quattro di Heidegger non sono però enti intramondani; sono in relazione, e questa è una delle sue ultime affermazioni: “l’essere ha bisogno dell’uomo per la sua rivelazione, custodia e configurazione”.
Nello svolgersi dei Quaderni Neri, i taccuini di tela cerata compilati nella pace della baita, l’idea di una Storia dell’Essere cede mano a mano il posto alla quadratura, e si susseguono osservazioni storiche, filosofiche, morali e personali in un flusso assai simile alle Illuminazioni di Ibn ʿArabī.
Proprio ibn ʿArabī specifica il reciproco bisogno che uomo e Dio nutrono l’uno verso l’altro: l’uomo ha bisogno di Dio per esistere, mente Dio ha bisogno dell’uomo per manifestarsi a se stesso.
Le ultime affermazioni di Heidegger sono talmente rivoluzionarie da essere, per esplicita volontà del filosofo, postume.
Protetto dalle persiane verdi della baita, incorniciate di blu brillante, il filosofo accoglie i cronisti dello Spiegel. L’occasione è un’intervista nella quale finalmente chiarire il suo coinvolgimento con il Nazionalsocialismo, ma presto si trasforma nel tentativo di ottenere una guida, di capire quale possa essere il futuro di una Germania affidantesi sempre più alla tecnica.
“Ci resta, come unica possibilità, quella di preparare (Vorbereiten) nel pensare e nel poetare, una disponibilità (Bereitschaft) all’apparizione del Dio”.
Alla domanda dello Spiegel: “Ritiene Lei che noi siamo in grado di avvicinare il Dio nel pensiero?”
“Noi non possiamo avvicinarlo col pensiero, siamo tuttalpiù in grado di risvegliare la disponibilità dell’aspettazione”.
Nel tentativo di spiegare la composizione delle sue Illuminazioni, nella volontà di convincere il lettore a non prendere il suo lavoro come dottrina, come dogmatica, Ibn ʿArabī le descrive come “un’attesa” per ciò che “sa apparire al cuore da dietro al velo”.
E l’attesa, insegna Heidegger, è una strada tutta di gioioso e ringraziante pensiero.


